
Inseriamo un articolo, tratto dalla Voce della Fogna, che parla ufficialmente dell'esperienza di Montesarchio. Il Campo Hobbit nacque da un'idea di Generoso Simeone, figura di spicco dell'area differente. La Valle Caudina ha la responsabilità politica di onorare una terra che ha visto nascere una nuova generazione destinata poi a spegnersi a colpi di pistola.
Altri tempi direte, altra mentalità, altra Italia.
Oggi abbiamo l'obbligo di GUARDARE AVANTI, il 1977 è un anno importante, ma appartiene al passato. La nostra "area" è chiamata a battaglie per difendere il presente e costruire un domani dignitoso.
Senza mezzi termini...
CHI VALE VOLA...
CHI NON VALE NON VOLA...
CHI VALE E NON VOLA...
E' UN VILE!
CAMPO HOBBIT I°
Forse, i lettori più affezionati e meno tarlati da forme di precoce arteriosclerosi galoppante ricorderanno la nostra promessa di soffermarci con la dovuta calma sulla esperienza new look di Campo Hobbit I. Assieme ad essa, rimembreranno l’ombra di un dubbio preventivo espresso sull'evento — che significato avrebbe questo rivestito per presenti ed assenti?
Forse, i lettori più affezionati e meno tarlati da forme di precoce arteriosclerosi galoppante ricorderanno la nostra promessa di soffermarci con la dovuta calma sulla esperienza new look di Campo Hobbit I. Assieme ad essa, rimembreranno l’ombra di un dubbio preventivo espresso sull'evento — che significato avrebbe questo rivestito per presenti ed assenti?
Un'esplosione occasionale e pulviscolare di repressi istinti di rivincita sul quotidiano, o il tanto agognato momento di confronto (e accidenti alle parole di moda!) — ottenuto con un sapiente amalgama fra spontaneità e organizzazione non coercitiva ma dinamica — fra il nostro mondo e la crisi profonda che da tempo lo attanaglia, momento capace di far sgorgare un modo originale di frequentarci e conoscerci, senza cadere nella banalizzazione del quotidiano e nella grettezza dell'egoistico?
Dubbi, premesse, programmi. Deponevano sfavorevolmente le incrostazioni acquisite in anni di sapiente diseducazione. L’abitudine allo scontato, l'incapacità del nuovo, l’accontentarsi del poco. L’incubo di una sopravvivenza quasi forzata da un trauma storico, da un antico parto cesareo. L’anatema per un rinnovamento sempre tacciabile di tradimento da parte degli stolti o dei più furbi. L'insistente insopportabile reiterarsi di formule di comodo capaci di assicurare un biascicato piatto di minestra, senza più la voglia, lo spirito, la mente lucida per proiettarsi aldilà degli steccati del conosciuto dello sperimentato, alla sola luce degli ideali.
Eppure, l'undici e il dodici giugno settantasette sono passati.
A Montesarchio e altrove. Dentro e fuori dal movimento, il nostro.
Una formula ha attaccato.
Uno stile, ammesso che sia nato, forse. A Latina, a fine settembre. Programma Domani, con una 'scaletta' articolata —grafica, musica, biopolitica — Qua e là, più sbiadite e talvolta sfocate, feste —chissà perché “popolari” - a macchia d’olio, in una geografia ancora incerta. E intanto, l’altro mondo. Bologna. il polo, la calamità. Il fascino sicuro e misterioso dell’indefinitezza. Gli autonomi e la ripresa tardiva delle migrazioni: fenomeno più numeroso, meno pungente di quello eroico degli stanchi hippies progenitori. Ieri con Kerouac e il pollice, oggi con la Colt ma sull'autostrada. Ieri, ebbrezza del tuffo nell'infinito — oggi orgasmo del posto di blocco sorpassato. E mille altre piccole e grandi sorprese.
Tanti bizzarri pianeti nell'ignoto universo delle generazioni: i rudi servizi d'ordine dei festivals democristiani, le padellate sul cranio delle sagre di Fronte Popolare; i campi di lavoro di CL, le veglie inaspettate di compagni scopertisi a dover sorvegliare le sezioni. Indizi di sabbie mobili; di un mosaico che spesso si dissolve e subito si ricompone. Anticipa le analisi e scavalca persino i più tenaci luoghi comuni.
E noi. Di fronte, agli altri, ignoti a noi stessi.
Una scatola misteriosa.
Era tempo di consuntivi, di soluzioni.
Nel paese dei fasci-dal-braccio-a-molla, per una buona sessantina di ore milletrecento ragazzi e ragazze a confronto con l'inaspettato: l'istinto di liberazione dal bisogno di omogeneizzarsi ogni giorno e ad ogni angolo; la incontrollabile e forse ingiustificata forza catalizzatrice del numero, della massa del muro.
EROI O MARIONETTE ?
Introno al dilemma sfogo o creazione, il Campo ha ruotato, talvolta ingranato, talaltra girato a vuoto. Il problema se un pezzo musicale, uno slogan, un poster, un murale dovesse rappresentare un atto gratuito o l'involucro di una carica rivoluzionaria destinata a trapassare le mura della emarginazione politica doveva pur porsi al movimento. Non tutti lo hanno capito, ma si è cominciato.
EROI O MARIONETTE ?
Introno al dilemma sfogo o creazione, il Campo ha ruotato, talvolta ingranato, talaltra girato a vuoto. Il problema se un pezzo musicale, uno slogan, un poster, un murale dovesse rappresentare un atto gratuito o l'involucro di una carica rivoluzionaria destinata a trapassare le mura della emarginazione politica doveva pur porsi al movimento. Non tutti lo hanno capito, ma si è cominciato.
La stessa scelta del luogo ha aperto il discorso sulla comunicabilità. E se qualcuno degli osservatori ‘ufficiali’ lo ha definito un lager, situando la propria attenzione sul terreno di esibizione, indubbiamente troppo appartato dalla vita «normale» di una cittadina, altri — pur dello stesso circolo vizioso della stampa con imprimatur di regime — hanno temuto l’innesco, l'impatto con la realtà circostante di una terra ai limiti della sopportazione, la curiosità di qualcuno «normale» di mettere il naso al di sopra del recinto dei «mostri». E proprio questa insperata e malevola cassa di risonanza (una terza pagina de La Repubblica semiegemonizzata, riducendo a mal partito il nuovo festival di Re Nudo, figlio bastardo del Parco Lambro) ha ovviato alle falle logistiche.
Si trattava, in fondo, di far sospettare a qualcuno che noi fossimo quello che siamo.
Né beatniks in ritardo, e nemmeno clowneschi puonal-fra-i-denti in attesa di un tram senza rotaie.
Certo i puri hanno arricciato il naso: che tanfo di plebe, nella tendopoli via via dilagante, capannelli e crocicchi con chitarre, un po' di amore neppur troppo furtivo di coppie senza certificati, parole succhiate sdraiati nell'erba. Sogni divaricati di critici prevenuti: gli uni sdegnati senza le sedie, il portacenere, il microfono sul tavolo e l'attesa fremente del duce-sei-tutti-noi, quale che sia, che si alza e celebra, stile hotel-convegno giacca e cravatta sennò non sei moderno, sei sospetto, sei un ultrà!
Gli altri alla ricerca dello spiazzato fra i monti, duemila a partire e dieci in cima, a contemplare con sovrano ritegno gli empi ed i vili talmente appesantiti dal loro essere materiale da rendere problematica l'ascesa prima ancora che l'ascési. Soli, assorti — ma con la certezza splendente della scelta: gli eroi, i portatori di fiaccola, i risvegliati.
Di tutto ciò, all'Hobbit, niente.
C'era ascetismo a buon mercato, yoga e meditazione ‘trascendentale’ [?], in quota, poco più in là: Re Nudo, appunto, o il recupero dell'irrazionale in nome del vecchio Rousseau toccato dalla sapienza di un guru.
«Ma è lo spirito con cui si fanno le cose che conta, e quelli...».
Senz'altro. Ma attenti alle fughe in avanti: accusare di copiare 'quegli altri’ in cose che ormai da troppo tempo non li attirano più (eppure funzionavano ancora benissimo; vi è mai sorto il dubbio che ci fosse qualcosa che «non girava» proprio dentro di loro? E il parco Lambro è nulla?) per non voler constatare che le ‘cose diverse’ le fanno, già adesso, sempre loro. Attenti a gettare il contenuto perché la bottiglia è stata insozzata dall’avventore...
È forse meglio crepare di sete o ripulire tutto e cercare il contatto col proprio gusto?
LA BALIA IN RIPOSTIGLIO
E’ mancata, forse, la spontaneità.
LA BALIA IN RIPOSTIGLIO
E’ mancata, forse, la spontaneità.
Non quella delirante della mitomania, piacevolmente annegata nel kitsch di una cinquantina di rampolli usciti freschi freschi da una pellicola di Lizzani, autentici prodotti di un transfert operettistico (quasi l’arcivernice del professor Lambicchi per staccare dalla tela le più improbabili figure e incarnarle nel museo vivente dell’assurdo), isolati se non ignorati dal grosso, ridotti a contorno malamente tollerato. Ouella della ricerca.
Perché di questo si sarebbe dovuto trattare: ricerca musicale (e non puro recital), ricerca grafica (non disegni già fatti, ma gente che dipinge, si corregge, si scopre, si conosce per quello che vale), ricerca — nessuno s'impenni — politica, per giungere ad una nuova dimensione nella sola occasione pubblica di questi anni per sfuggire al commento del dato e dell'ovvio, per capire che intorno il mondo pulsa e che ci deve pur essere un modo per vivere questo nostro status di diversi nella pienezza di una risposta articolata alla fabbrica di consuetudini che ci circonda.
Alle volte, ci siamo arrivati.
Una musica armonica nei fini e nei contenuti, fatta per gioire ma al tempo stesso per sfondare il muro dell'incomprensione, si è sentita sbucare.
A che pro accumulare pile di libri in casa propria, parlare di «luci del Medioevo» e soffocare i muri di una stanza di posters grondanti elmi, asce, cavalieri e ignorare un tipo di ricerca — melodie medioevali, celtiche — ceduta al nemico gratuitamente?
Renato Colella, voce sperduta in quel di Avellino, ha sfondato il muro di cartapesta con un magnifico impasto di suono e poesia, Altafronte. Una strada aperta da frequentare, un varco consistente attraverso il quale calarsi furtivi a frotte nella cittadella di questo mondo, al cui margini stiamo accampati non per un atto di presenza ma studiando il momento migliore per dargli l'assalto e cacciarne gli infami occupatori e tiranni.
Senso scenico e capacità di fusione hanno dimostrato Gli amici del vento, magnifico cuib milanese; ai loro testi pieni e scorrevoli, impietosamente taglienti in una dimensione lontana dalia retorica, ravvivata da bagliori sottilmente autoironici (Incontro, Trama Nera) dobbiamo l'esplosione di lunghi momenti di comunità, il palpabile estinguerei dalla crisi di identità che ci attanaglia nelle nostre espressioni più esterne. La prova vivente che tutto serve per riscoprire i nodi profondi di un modo di essere, di vivere, di creare.
Meno bene l'impatto col nuovo. Specchio della marginalizzazione del militante nel quotidiano, lo stupore smarrito del mucchio di fronte al concerto di Janus. Forse, con Colella, la carta più azzeccata per uno slancio di penetrazione. Un rock duro, violento, sfibrante, fra le cui battute ossessive capaci di schiacciare una folla QUALSIASI messaggio sferzante potrebbe esser fatto passare. Ne parleremo a Mosse, qualora volesse scrivere un volume secondo de «La nazionalizzazione delle masse». Il nuovo ancora, sul campo e fuori, negli spazi inter-musicali. Niente secchi comandi da capomanipolo, niente boss da servire. Per molti, una dimensione piena. Per altri, lo smarrimento alla ricerca della balia perduta.
I dibattiti, lo scambio di idee, qualche sensazione vissuta in comune.
Un piccolo, correggibile esempio di una rivoluzione di comunità che potrebbe regalarci la forza dirompente del tempo libero, il veicolo più sicuro, oggi, per fracassare le ossa a chi ci aspetta solo al varco del comizio, del corteo, del volantinaggio o dell'affissione.
Nell’affissione dei tabù, certo, molto gusto infantile: la rivendicazione del barattolo rotto di marmellata finalmente sottratto a papà. Ma anche la tangibile constatazione di un mondo in via di creazione: dove ognuno può avere un ruolo per i suoi interessi e non solo per i suoi muscoli; per gli usi indiretti dei suoi grammi di materia grigia.
Nell’affissione dei tabù, certo, molto gusto infantile: la rivendicazione del barattolo rotto di marmellata finalmente sottratto a papà. Ma anche la tangibile constatazione di un mondo in via di creazione: dove ognuno può avere un ruolo per i suoi interessi e non solo per i suoi muscoli; per gli usi indiretti dei suoi grammi di materia grigia.
Il personale è politico.
Un messaggio che avrebbe dovuto esser chiaro da sempre, a chi mastica echi di Tradizione e di weltanshauung, si è udito nella sua totalità. Nessun tema sporcato di qualunquismo; un continuo Intrecciarsi di tesi senza il tedio insopportabile del tran tran di circolo, di gruppo, di sezione. Anche se non tutte le orecchie erano sturate: inevitabile risultato, nel paese dei tappi di cera. Abbiamo preso le misure di noi. Sappiamo di poter penetrare dovunque, utilizzare qualunque veicolo per proseguire la marcia verso la nostra rivoluzione.
Sappiamo anche che il cammino sarà lungo, e non pochi ci lasceranno per strada.
Curiamo a tempo di saper far salire in fretta chi più se lo merita. Non basta non ripetere pedissequamente gli schemi frusti del festival dell'Unità. Ne può abbatterci il fatto di non sapere far uscire da un Campo un lucido 33 giri, come per II Parco Lambro; ma solo una stirata cassetta-ricordo o testimonianza da chiedere a tremilacinquecento lire alle Edizioni Europa (via degli Scipioni 268/A - 00192 Roma) per ignari, ignavi e neòfiti. Questo verrà, se sapremo essere noi anche fra gli altri; se lasceremo una volta per tutte il fardello dei distinguo e della puzza al naso per vivere il nostro apostolato, la nostra missione, la nostra Riconquista.
Tutto questo ci porterà ben al di sotto delle paludi, ma... allora, perché Hobbit?
Perché Tolkien? Una domanda da porre ai tanti, ai troppi venuti a vivere due giorni di attesa e non di partecipazione, senza neppure sapere cosa quel nomignolo strano stesse a significare. Hobbit, Tolkien per dire la capacità di vivere, di rappresentare, il fascino di un mondo lontano e presente.
Godibile oggi, ma su un altro piano.
Proponibile domani, nel dominio delle scelte di un’esistenza. Hobbit per rimembrare la speranza di un’evasione nel reale, in un altro paio di noi — per rinnovare il miracolo di milioni di giovani, ovunque, abbarbicati ore e ore a un insieme quasi illimitato di fogli di carta sottile, sperduti nel sogno che può non finire…
il desiderio di infinito di un hitch-hiker kerouacciano, il fascino ambiguo e sfaldante di un sessantotto non fatto di assemblee e discorsi, ma di sacchi a pelo e di confessioni insieme.
Il motore del cambiamento, per chi sfugge l’orizzonte arcinoto del ventre pieno e del portafogli gonfio.
Questo, ed altro, è Hobbit: lo è, e può diventarlo…






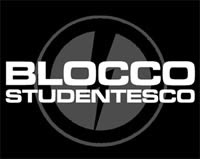





























































Nessun commento:
Posta un commento